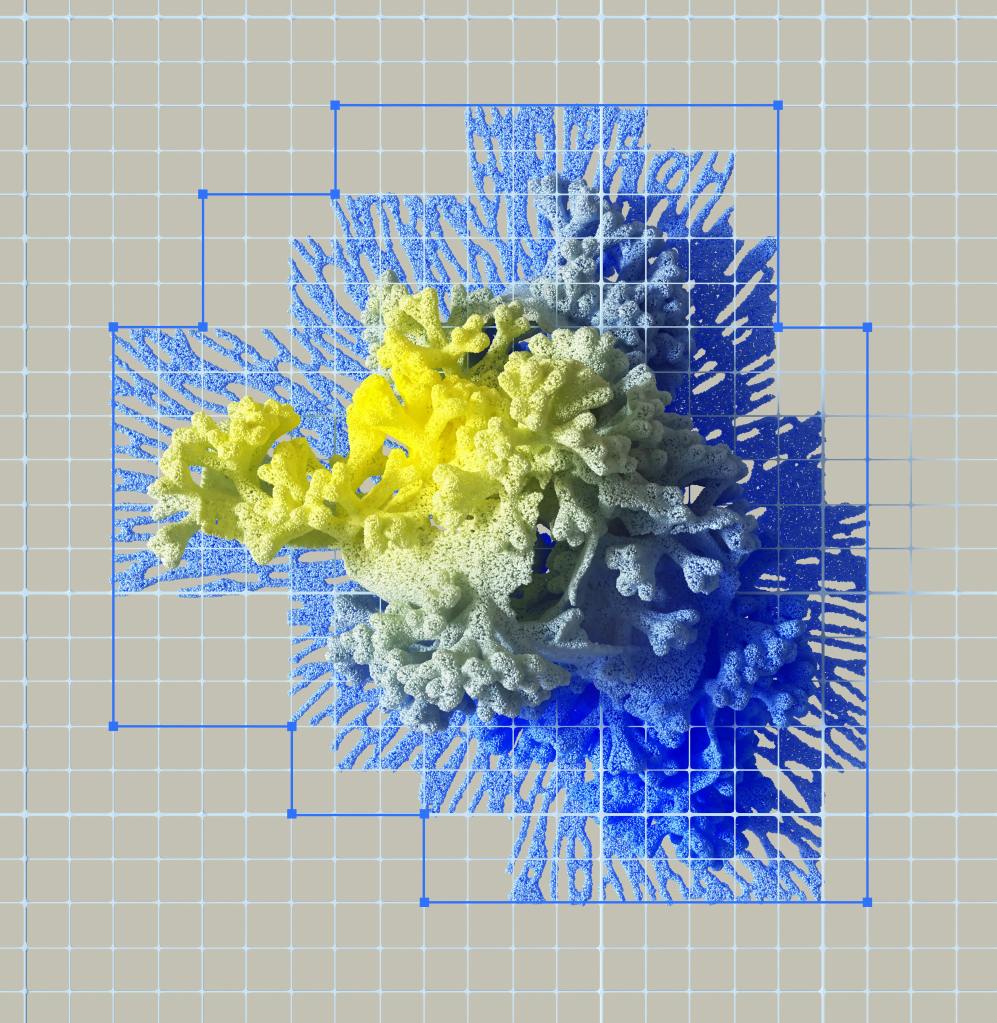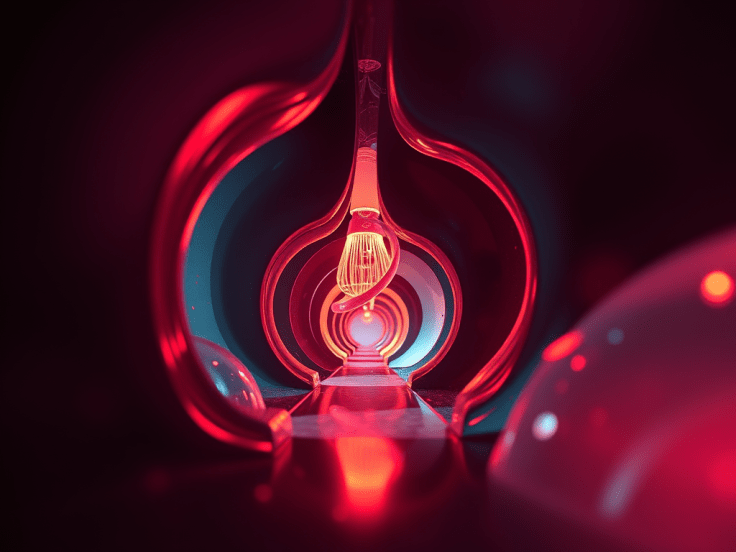Pensavo al senso di (non) pubblicare più i propri versi inediti su rivista o blog online in Italia, specie se non accompagnati da un cappello introduttivo critico. Il punto è che mai e poi mai sembra generarsi un dibattito o uno scambio, o altro tipo di conseguenza, a partire da quella pubblicazione. Certo, lettrici e lettori si tengono informati, si vede quello che circola (spesso deprimente, derivativo, soprattutto privo di implicazione col proprio tempo, eccetto per un generico richiamo alle tecnologie…), e quindi il servizio offerto a loro è reale. Per autrici e autori, però (ovvero: per quegli stessi lettori nei panni di autori), assai meno.
Questa situazione, come si sa, è vera almeno da un quindicennio, cioè da quando i blog letterari hanno perso, per complessi motivi tecnologici (l’avvento dei social media) e forse culturali, quella vivacità di scambio e piglio critico che ancora avevano nel primo decennio del duemila, e che io ricordo ancora, benché nella fase morente – essendomi affacciato a quel mondo intorno al 2005-2006, appena ventenne. In sostanza, la massa dei testi inediti pubblicati su blog online e riviste diventa rumore di fondo (se non persino silenzio, cioè rumore non intercettato affatto) e benzina di auto-alimentazione delle varie piattaforme che li accolgono. Forse diventano più utili i testi alle piattaforme che viceversa. Altro discorso andrebbe invece fatto sulla pubblicazione di estratti di un libro appena uscito, dove la pubblicazione online è legittimo veicolo verso il libro.
La ritrosia al confronto non è cosa nuova, a ogni modo. Ricordo quando partecipai a un festival, di cui non occorre fare il nome, nel lontano 2011. Con ingenuità ma convinzione, prima di leggere dal palco, dissi qualcosa per incoraggiare il pubblico eventualmente a criticarmi, dopo la lettura, o a ricevere un riscontro qualsiasi sui miei testi. Chissà cosa avranno pensato: si trattava di una richiesta del tutto irrituale in quel contesto. Ma ecco, le letture fluivano anche lì una dopo l’altra in una totale mancanza di attrito e di scambio, e io mi limitavo a esprimere il mio dissenso verso alcune scritture semplicemente riducendo il tempo e l’intensità dell’applauso, o non applaudendo affatto. A che serve tutto ciò?
Altra circostanza. Nel 2015 pubblicai su Poesia un poemetto allora inedito, per una rubrica di autori esordienti o in via di affermazione, con introduzione di Maria Grazia Calandrone. Fu ovviamente una grande soddisfazione a livello personale, diciamo pure a livello di curriculum letterario. Senza contare la consapevolezza di poter essere letti da centinaia (migliaia?) di abbonati. Pure da lì, però, non derivò nessun altro riscontro, la comunità dei lettori restava come una chimera o una massa che sguscia via.
Non lo dico per lamentarmi: constato un’esperienza che credo sia comune a tantissimi tra coloro che scrivono, e che considerano la scrittura una parte insopprimibile della propria vita e a cui dedicare molto del meglio delle proprie energie.
Mi viene da fare questo discorso non soltanto spronato da un recente intervento sull’antagonismo in letteratura, scritto da Andrea Temporelli su Pangea; ma anche memore di una lezione online recente (tre settimane fa), di cui parlerò estesamente per altri motivi in futuro. In questa lezione online, io e alcuni docenti di scrittura creativa attivi in Inghilterra, davamo consigli a studenti che volessero proporre le proprie opere a varie riviste online e cartacee in lingua inglese. Io credo che anche lì ci sia la stessa proliferazione di rumore, la stessa difficoltà di lasciare qualcosa che possa artigliare, che riscontro in Italia. Tuttavia, c’è una differenza fondamentale: pubblicare su riviste e blog letterari in lingua inglese è molto difficile, ed è normale che i propri testi vengano rifiutati.
Quando uno dei docenti mi ha chiesto come reagisco io a questa esperienza di rifiuto, mi sono sentito braccato: in Italia è quasi automatico venire accettati, se si manda materiale inedito, oppure ignorati e basta, se non si è in rapporti cordiali oppure se si utilizza la email ufficiale che esiste ma nessuno usa. Mi sento sentito di nuovo un provinciale, uno alle prime armi, malgrado tutto. Il fatto è che, forse con la sola eccezione della rivista minima, non c’è un iter chiaramente competitivo, e quindi non c’è nemmeno la prospettiva di una “carriera letteraria” del tipo anglosassone: pubblichi prima per piccole riviste indipendenti, ti fai conoscere, e poi se hai costanza e forse bravura approdi alle riviste prestigiose, che permetteranno infine l’aggancio con gli editori. Lo stesso sistema Submittable permette di tenere sott’occhio i propri invii, e sarebbe facilissimo, a livello tecnico, adottarlo anche in Italia – tanto è vero che sul mio sito, in fondo alla pagina Critica/Criticism, ho inserito un modulo per l’invio, più artigianale certo, ma si tratta pur sempre di un sito personale fatto da una persona dalle risorse tecniche ed economiche limitate.
A me pare che in Italia esista invece un pervicace presentismo destrutturato, una dispersione di centri non comunicanti e non interagenti. Perfino vincere lo Strega Poesia non garantisce in fondo che la propria opera venga studiata, discussa, tradotta e presentata all’estero. Se esiste serietà a monte, spesso si fa fatica a percepirla, perché tutto è fatto con approssimazione e non nella prospettiva di offrire un vero servizio pubblico.
Paradossalmente, pare che proprio sui social media avvengano scambi più vivaci quando si pubblicano i propri testi. Io ogni tanto lo faccio, ma rimango restìo perché – forse per uno strascico aristocratico o elitario – mi pare di sprecare o svendere il mio lavoro condividendolo sui social. Una via di mezzo è la condivisione sul proprio sito personale o nuove piattaforme come Substack. Mi sembra però una via fin troppo facile (specie per i testi sui quali si punta di più), perché secondo me la verifica incrociata degli addetti ai lavori (come avviene in ambito accademico, dove comunque esistono altri enormi problemi di cui parlerò a tempo debito) è assai importante per valutare la tenuta del proprio lavoro.
Non ci sono soluzioni a breve termine. La soluzione sarebbe, piuttosto, quella di costruire istituzioni forti, a livello di procedure trasparenti e rigorose. Sto imparando molto in tal senso da impegni che mi sono preso nelle associazioni accademiche di cui faccio parte, e chissà che questo know-how non possa un giorno tornare utile per sperimentare un cambio di rotta nel modo di fruire e presentare la poesia contemporanea in Italia.
Nel frattempo, il lavoro di scrittura continua ma cerca di evitare la (sovra)esposizione, per motivi direi più che fondati.